S:2 – Ep.43
Giacomo dalla Chiesa è una persona qualunque.

Giacomo nacque a Genova da famiglia nobile ma non più particolarmente benestante, terzo di quattro figli di Giuseppe della Chiesa e di Giovanna dei marchesi Migliorati.
La famiglia della Chiesa era discendente da casati che avevano dato i natali a Berengario II d’Ivrea, conte di Milano e marchese di Lombardia e d’Ivrea e re d’Italia dal 950 al 961, e ad un pontefice, Callisto II, 162º papa della Chiesa cattolica dal 1119 fino al 1124; i dalla Chiesa facevano parte del patriziato genovese, nel quale aveva raggiunto, nel XVI secolo, una posizione di particolare rilievo, ma non era da meno la famiglia materna, ugualmente aristocratica, i Migliorati di Napoli che avevano già dato, anche loro, i natali a un pontefice, Innocenzo VII, 204º papa della Chiesa cattolica dal 1404 al 1406.
A Genova Giacomo ebbe modo di formarsi in un ambiente fecondo sia sul piano della fede sia su quello della cultura: fondamentali furono la frequentazione del beato Tommaso Reggio, dei futuri cardinali Gaetano Alimonda e Giorgio Rea e del futuro primo vescovo di Chiavari Fortunato Vinelli.
Su pressione del padre, il quale si era opposto al desiderio di Giacomo di entrare quanto prima nel seminario diocesano, si iscrisse nel 1872 alla facoltà di giurisprudenza della Regia Università degli Studi di Genova, dove si laureò dottore in legge nel 1875.
Solo allora il padre acconsentì a fargli intraprendere la carriera ecclesiastica; impose tuttavia al figlio di proseguire gli studi, iniziati presso il seminario di Genova, e a Roma, presso il Collegio Capranica e la Pontificia Università Gregoriana, dove Giacomo della Chiesa ottenne la laurea in teologia.
Dopo essere stato ordinato presbitero il 21 dicembre 1878 dal cardinale Raffaele Monaco La Valletta, entrò nell’Accademia dei nobili ecclesiastici per la preparazione alla carriera diplomatica, e successivamente, nel servizio diplomatico della Santa Sede.
Quando il cardinale Rampolla, dopo l’elezione di Pio X, fu sostituito dall’altrettanto valente Merry del Val, Giacomo della Chiesa mantenne inizialmente il proprio posto, stimato dal nuovo Papa per le sue capacità.
Pio X, pur apprezzandolo, decise però di allontanarlo dalla Curia romana e il 16 dicembre 1907 lo nominò arcivescovo di Bologna, secondo la nota massima latina promoveatur ut amoveatur, così giunse a sorpresa a Bologna la sera del 17 febbraio 1908.
Monsignor della Chiesa sosterrà l’intervento italiano in Libia, in conformità con la dottrina della guerra giusta, un campo di riflessione della teologia morale cristiana che stabilisce a quali condizioni dichiarare una guerra, e combattere per vincerla, sia lecito per un cristiano.
Nel capoluogo emiliano, nonostante la sede di Bologna fosse tradizionalmente titolata per una berretta cardinalizia, della Chiesa fu creato cardinale di Santa Romana Chiesa da Pio X solo sei anni dopo, il 25 maggio 1914, due mesi prima dell’inizio della Grande Guerra.
E proprio nel primo mese della prima guerra mondiale, Pio X morì per una cardiopatia, il 20 agosto 1914, si dice che qualche tempo prima della morte, profeticamente, abbia detto più volte sconsolato: “Verrà il guerrone”, ossia la Grande Guerra.
Giacomo dalla Chiesa, benché inizialmente Bologna fu vista come un passo indietro nella sua carriera ecclesiastica, proprio quell’esperienza pastorale lo rese possibile alla sua elezione al soglio pontificio, tant’è che solo dopo quattro mesi da quando era diventato cardinale, il 3 settembre 1914, fu inaspettatamente eletto papa, nonostante l’opposizione dei cardinali curiali e di quelli più intransigenti, tra cui De Lai e Merry Del Val.
Assunse il nome pontificale di Benedetto XV in onore del pontefice Benedetto XIV, che a sua volta era stato arcivescovo metropolita di Bologna prima di salire al soglio pontificio come lui.
L’elezione a papa di un cardinale nominato da soli tre mesi fu un evento eccezionale, probabilmente fu la situazione bellica a favorire la sua elezione, avendo egli lavorato nella diplomazia con valenti segretari di Stato ed essendo considerato più super partes rispetto ad altri papabili.
Infatti, durante la prima guerra mondiale elaborò diverse proposte di pace, nella sua prima enciclica, pubblicata già il 1º novembre 1914, si appellò ai governanti delle nazioni per far tacere le armi e mettere fine allo spargimento di tanto sangue umano.
Fu lui, il mese successivo, che chiese una tregua natalizia dicendo: che i cannoni tacciano almeno la notte che cantano gli angeli, ma non fu ascoltata dagli ufficiali, mai dai soldati sì, i militi dei vari schieramenti smisero di spararsi e si incontrarono nella terra di nessuno scambiandosi piccoli doni in quello che fu poi ricordata come la tregua di Natale.
Con l’entrata in guerra anche del Regno d’Italia il 24 maggio 1915, la Santa Sede, chiusa e «prigioniera» in Vaticano, rimase ulteriormente isolata con la dipartita degli ambasciatori degli Stati esteri.
Durante tutto il conflitto non smise di inviare proclami per la pace e per una risoluzione diplomatica della guerra, oltre a fornire aiuti concreti alle popolazioni civili colpite, tra cui servizi di soccorso per i feriti, i rifugiati e gli orfani di guerra.
Tra tali aiuti, il cui costo portò il Vaticano sull’orlo della bancarotta, va ricordata anche l’apertura di un ufficio in Vaticano, l’Opera dei prigionieri, finalizzato alle comunicazioni e al ricongiungimento dei prigionieri di guerra con i loro familiari.
In campo diplomatico, nell’aprile e nel maggio 1915, cercò di operare come intermediario tra l’Austria-Ungheria e l’Italia per evitare che la seconda dichiarasse guerra alla prima; non riuscendoci, e tra la fine del 1916 e l’inizio 1917 si adoperò come tramite fra alcune potenze dell’Intesa e il nuovo imperatore, Carlo I d’Austria, fino a che, nella primavera del 1917, si appellò al presidente degli Stati Uniti Woodrow Wilson nel tentativo di prevenire l’entrata in guerra dell’America, fallendo anche in questa occasione, ma per pura ragione politica.
La risposta delle nazioni belligeranti fu negativa, specialmente quella di Woodrow Wilson che accolse il messaggio in modo critico e distaccato, e ciò si rivelò determinante nell’assicurare il fallimento delle proposte di pace di Benedetto XV perché ormai gli Stati Uniti erano entrati in guerra e le altre potenze dell’Intesa dipendevano sempre più dal contributo statunitense allo sforzo bellico.
Il suo tentativo più audace per fermare il conflitto e indurre i capi delle potenze belligeranti a riunirsi intorno a un tavolo di pace fu tuttavia la Nota del 1º agosto 1917, una lettera comunemente ricordata per aver definito la guerra come «inutile strage».
In aggiunta, la sua imparzialità venne interpretata dalle varie fazioni come sostegno verso la parte avversa, mentre in Francia venne denunciato come “il papa crucco” (le pape boche), in Germania venne definito “il papa francese” (der französische Papst) e in Italia, addirittura, “Maledetto XV”».
In ogni caso, l’ostacolo più grande per il pontefice fu, a fronte della sua posizione di ferma condanna della guerra, l’adesione pressoché totale e incondizionata ad essa da parte dei cattolici e del clero dei vari paesi belligeranti.
In Francia si era realizzata un’union sacrée contro i tedeschi con la piena partecipazione dei cattolici e del clero allo sforzo bellico, dall’altra parte, in Germania, i cattolici indugiavano, dal loro consenso entusiastico alla guerra dipendeva la definitiva consacrazione del proprio ruolo nazionale.
Anche in Italia la grande maggioranza dei cattolici organizzati e la grande maggioranza dei vescovi, pur con diverse distinzioni e sfumature, aveva finito per aderire senza riserve alla guerra e tale adesione causò inevitabilmente una netta contrapposizione tra le varie chiese nazionali, che il papa ammise di non poter governare.
Così com’era da ricondurre a Dio l’origine del conflitto mondiale, anche la sua fine è riconosciuta da Benedetto XV come opera di Dio, tesi che viene esplicitata nell’enciclica Quod iam diu.
Al termine del conflitto il papa si adoperò per riorganizzare la Chiesa nel nuovo contesto mondiale, riallacciò le relazioni diplomatiche con la Francia con cui i rapporti si erano drasticamente deteriorati a causa della Legge di separazione tra Stato e Chiesa del 1905, anche grazie all’apprezzato gesto simbolico della canonizzazione di Giovanna d’Arco, e con altre nazioni; se all’inizio del papato Benedetto XV poteva contare su relazioni diplomatiche con 17 stati, sette anni dopo questi erano saliti a 27.
Una mattina del gennaio 1922, Benedetto XV celebrò la messa per le monache alla Domus Sanctae Marthae, e, una volta uscito dall’edificio, si espose al freddo e alla pioggia in attesa dell’arrivo del suo autista.
Il 5 gennaio il pontefice iniziò a manifestare i primi sintomi influenzali, e una settimana dopo, il 12 dello stesso mese, comparve una forte tosse e si presentava febbricitante, questi sintomi furono il preludio di una terribile broncopolmonite.
Le sue condizioni migliorarono leggermente verso la mezzanotte del 20 gennaio e lo stesso pontefice insistette sul fatto che i suoi assistenti medici si ritirassero per la notte, quando ormai sembrava che potesse riprendersi, alle 2:00 del 21 gennaio, gli fu data l’estrema unzione.
Nonostante ciò, a mezzogiorno iniziò a delirare e insistette per alzarsi per riprendere il suo lavoro, ma un’ora dopo cadde in coma.
Il dottor Cherubini annunciò la morte del pontefice alle 6:00, dopo la sua morte furono fatte sventolare bandiere a mezz’asta sugli edifici governativi: il gesto fu considerato un omaggio al papa che aveva contribuito al miglioramento delle relazioni tra la Santa Sede e lo Stato italiano.
Il suo corpo fu vestito degli abiti pontificali ed esposto ai fedeli prima di essere, dopo i solenni funerali, sepolto nelle Grotte Vaticane, di fronte alla tomba del suo predecessore Pio X.
Il 6 febbraio dello stesso anno papa Pio XI ne divenne il successore e fu il 259º vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica dal 1922 alla sua morte nel 1939, dal 7 giugno 1929 fu il primo sovrano del nuovo Stato della Città del Vaticano.
Ma questa, è un’altra storia.
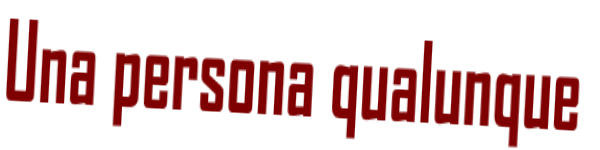
100 episodi del Podcast gratuito anche su Spotify.




